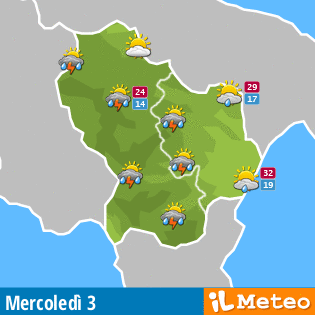Non possiamo fare a meno di portare la nostra mente a quell’antico castello di un certo rilievo, ma dimenticato ed abbandonato, di Palazzo San Gervasio,
Non possiamo fare a meno di portare la nostra mente a quell’antico castello di un certo rilievo, ma dimenticato ed abbandonato, di Palazzo San Gervasio,
il quale è ubicato su di una collina amena a quasi 500 metri sul livello del mare. Esso risale all’epoca normanna, mentre il suo riattamento fu quasi certamente fatto eseguire su progetto di Federico II, che oltre ad essere un grande condottiero ed un sagace ed accorto politico, fu pure un valente ingegnere.
Il maniero fu fatto erigere sul colle che domina la pianura sottostante e dal quale si delineano, con nitida evidenza i rilievi del Melfese, del Gargano, del pescoso golfo di Manfredonia, della rocciosa Murgia e della vicina Puglia, molto probabilmente da Drogone di Altavilla, conte di Puglia (1046-1051), o dal fratello Umfredo che gli successe (105 1-1057).
La sua costruzione, come palatium regium (casa padronale), risale al 1050 circa; esso aveva prima forma quadrata, che è la forma tipica degli edifici militari normanni, con due torrioni ai lati a pianta quadrata e che, con il tempo e l’opera vandalica degli uomini, sono andati del tutto distrutti. Vi erano anche quattro bifore e una trifora centrali simili ad una loggia, che ancor oggi si possono scorgere, anche se murate; in seguito il primitivo disegno architettonico fu completamente modificato.
Il castello fu prima destinato a residenza di campagna dei principi normanni e come luogo di caccia e di svago degli Svevi: domus solatiorum; in seguito come posto di vedetta e di difesa del territorio ricco di boschi e di pascoli contro i Saraceni che scorazzavano ancora nella vicina Puglia o contro i Bizantini o Greci che combattevano contro i Normanni, i quali volevano a qualsiasi costo soppiantarli, come attestano i cronisti coevi.
Intorno e vicino all’ostello vennero costruite di poi delle casette per il personale dipendente, le quali cominciarono a formare quel rione che si chiamò Santo Spirito e che aveva al suo centro una chiesetta, non più esistente sin dalla fine del cinquecento, costruita probabilmente, ad opera di devoti lombardi, al servizio dei Normanni (altrimenti non si riuscirebbe a spiegare l’intitolazione della chiesa, nel bel sud d’Italia, a martiri cristiani del nord) dedicata ed intitolata ad uno dei santi martiri del cristianesimo: Gervasio fratello gemello di Protasio, di cui si parla in due Bolle pontificie di Pasquale II (1099-1118): datata, dal Laterano, la prima, 22.5.1103, in cui si accenna all’esistenza di detta Chiesa: «Ecclesiam Sanctorum martyrum Gervasii et Protasii in Bandusino fonte apud Venusiam»; la seconda, datata da Albano il 16.6.1106, in cui si pone la stessa alle dipendenze dell’Arcivescovo di Acerenza.
Ma l’Ughelli riporta ancor prima un’altra carta del 1082 —ricordata pure da G. Racioppi — in cui si accenna ad un Casalis Gervasii e precisamente la donazione del territorio di questo casale al monastero della SS. Trinità di Venosa.
Inoltre nella Bolla pontificia dei 10.12.1201 di Innocenzo III (1198-1216) ritroviamo invece, proprio il nome di Palatium Sancti Gervasii.
Di lì a non molto l’imperatore Federico Il fece riattare il castello che gli doveva servire prima come luogo di caccia — che era il suo hobby preferito — e dopo come posto ideale — a causa dei ricchi pascoli ivi esistenti — per l’allevamento della razza dei cavalli, cosiddetti murgesi, allora molto richiesti, e specie quella dei cavalli arabi che l’augusto sovrano, tra le altre, preferiva. In queste scuderie venivano anche selezionati, a cura di un magister aratiarum, i superbi stalloni di razza reale che facevano spicco durante i fastosi cortei imperiali.
Ma il castello fu più frequentato e divenne molto più celebre al tempo di re Manfredi (1232-1266), figlio naturale di Federico II e di Bianca, il quale, dopo la vittoria conseguita durante la battaglia di Foggia, nell’estate del 1255, vi soggiornò a lungo.
Infatti il valoroso principe, ancora ventitreenne, in quel castello, dopo la suddetta vittoria sull’esercito pontificio comandato dal cardinale di Santa Maria in Lata, Ottaviano degli Ubaldini, legato del papa Alessandro IV (1254-1261) e considerato a torto dalla opinione pubblica del tempo come il traditore della causa guelfa per aver stipulato, dopo la sconfitta di Foggia, un trattato con Manfredi in cui egli assecondava i disegni del principe a discapito della causa pontificia (la logica delle cose vuole, però, che chi perde deve sottostare alle proposte del vincitore, pena la ripresa delle ostilità che il Cardinale in quel momento non era in grado, in nessun modo, di affrontare), si ritirò con il suo seguito per ristorarsi dalle fatiche della guerra. Il luogo, d’altronde, era ameno per la salubrità dell’aria e per la copiosità delle acque limpide e salutari e venationibus delectabilem — secondo scrive il cronista Jamsilla, ma, tra i sollazzi della caccia al cinghiale, al cervo e al daino e i refrigeri del bosco33 vicino, il giovane principe, aliquantum aegrotavit, si ammalò molto probabilmente di broncopolmonite tanto che fu prossimo alla morte.
Di questo maniero, facente parte dell’immenso patrimonio della Corona regia, il biondo re nominò poi, castellano, Nicola di Venosa, suo valletto preferito e familiare.
Ebbene, quivi Manfredi, per il vigore della sua età giovanile, riuscì a ritrovare la salute e la serenità dell’animo tanto che, durante la convalescenza, egli pregava spesso gli amici che l’avevano seguito e che affettuosamente gli tenevano compagnia di leggergli il Liber de pomo sive de morte Aristotilis, attribuito allo Stagirita, sia per rivolgere la mente a pensose meditazioni sul destino degli uomini dopo la morte e sulle speranze dell’aldilà, sia per confortare e sollevare gli animi, di chi gli stava amorevolmente d’intorno, dallo stato di afflizione in cui continuamente erano vissuti a causa delle sue precarie condizioni di salute.
Fu proprio durante questo periodo che Manfredi prese altresì a tradurre dall’ebraico in latino il suddetto libro che il più grande dei saggi arabi, Ibn Sabin da Mursia (1216-1270), invitato a Palermo dal padre Federico (1240) ai tempi dello splendore della Magna Curia, aveva portato seco dalla Tunisia in Sicilia, ove era stato poi tradotto dall’arabo da Abraham ben Samuel ha-levi (Ibn) Chasdai da Barcellona tra il 1235-40.
Il principe era circondato dall’affetto degli amici più cari che formavano il suo cenacolo letterario e giuridico: quali, per esempio, il suo segretario e cronista napoletano, tale Niccolò de Jamsilla, che nella sua cronaca lo chiama paternae philosophiae inhaerens — figlio ed alunno della filosofia —; Messer Gervasio di Martina, pugliese e giureconsulto illustre e uomo di grandi maneggi; il conte Manfredo Maletta, camerlengo del re e suo amato parente, il quale era «il migliore in trovare canzoni e melodie e che a sonare non aveva l’eguale al mondo»; Ermanno Alemanno — forse di origine tedesca, ma trapianta-to nel bel meridione d’Italia e che nel 1256 tradusse per lui la Poetica di Aristotele dal Breviario di Averroé: i fratelli Lancia parenti per parte della madre Bianca e tanti altri.
Pertanto Manfredi, in compagnia di costoro, godendo dell’aria salubre del luogo — specie per il ricco bosco vicino e ancor oggi lussureggiante di vegetazione — o affacciandosi dalle finestre o dalle logge di stile classico, una volta esistenti, da cui si poteva abbracciare con lo sguardo tutto un rilievo collinare delle Murge sul quale dominava la fortezza del Garagnone, o forse portandosi con essi presso la vicina fons bandusiae— di oraziana memoria — le cui acque salutari e più chiare del cristallo sgorgano dalla sorgente del monte di Palazzo San Gervasio, poté ritemprarsi fisicamente e spiritualmente tanto da poter attendere ai filosofici conversari, memore degli insegnamenti severi ricevuti negli atenei di Parigi e di Bologna, dove l’augusto genitore l’aveva mandato a studiare ed ove aveva acquistato ìncomparabilem scientiam .
Alla traduzione dell’opera aristotelica il giovane studioso premise anche un magnifico Prologo in latino, buona parte del quale è stato tradotto in italiano da Francesco Torraca (1853-1939), lucano di Pietrapertosa.
In esso Manfredi non fa che ribadire la sua ferma fede cristiana nella immortalità dell’anima, affermando che «la morte non è da temere in quanto essa non è che la dissoluzione dei quattro elementi empedoclei e che è necessaria perché l’anima abbia a raggiungere in Dio la perfezione cui a spira» e aggiunge inoltre che « gli uomini, per possedere il premio della loro perfezione non confidano nei loro meriti, ma nella immensa bontà del Dio creatore».
E chissà che padre Dante non si sia ispirato alle parole di Manfredi — del quale molto probabilmente conosceva l’opera allorché nel terzo canto del Purgatorio fa parlare l’anima del re svevo.
Dopo la sconfitta di Manfredi a Benevento il 26 febbraio 1266 e con l’avvento al trono di Napoli e di Sicilia di Carlo d’Angiò (1220-1285), fratello del Re di Francia Luigi I’, il Santo, il maniero di Palazzo San Gervasio, con tutte le pertinenze — le cui stanze erano state allietate dalla presenza di tanti nobili e raffinati uomini di cultura — fu subito adibito dal vincitore angioino solo come scuderia reale e relativa Marescalla.
Infatti, con la successiva occupazione di tutto il Regno di Napoli, re Carlo istituì, con Ordinanza del 1267, il Tenimento di San Gervasio come una delle Difese della Basilicata, consegnandolo al Maestro delle Regie Foreste con castellano e quattro guardie forestali a cavallo e quattro a piedi.
In una carta ancora del 1280 è menzionata la Marescallia S. Gervasii ove i re angioini possedevano le migliori scuderie di razze equine e il Palazzo e le masserie rurali molto probabilmente furono il primo nucleo del paese.
Durante il regno di Carlo Il d’Angiò, detto lo zoppo (1285-1309) e figlio del primo, il Castello di Palazzo fu assegnato ad un certo Filippo di Grandiprato, il quale fu nominato anche custode delle foreste di San Gervasio.
Nel 1334 re Roberto d’Angiò (1309-1343), figlio di Carlo Il, nominò il principe di Altamura, Beltrando del Balzo, -Custode delle foreste e delle Difese - del territorio di San Gervasio e Lagopesole, nel Giustizierato di Basilicata.
Sotto il regno di Giovanna I d’Angiò (1343-1382), nipote di Roberto, invece, ebbe inizio la trasformazione delle Regie Difese in Feudi; la quale fu continuata da Carlo III d’AngiòDurazzo (1382-1386) e da suo figlio re Ladislao d’AngiòDurazzo che nel 1400 donò alla madre Regina Margherita il « Tenimento di Palazzo San Gervasio con il castello (elevandolo a Feudo) e la terra di Stigliano». Il primo atto di infeudazione è del quattrocento, allorché la regina di Napoli Giovanna Il, detta Giovannetta (1414-1435), figlia di Carlo III d’Angiò-Durazzo e sorella del valoroso, cedette, nel 1434, «e’ regesto serenissimae Reginae Joannae Secundae» (signato 1423 fol. 427), alla nipote cugina Covella o Cubella Ruffo, contessa di Montalto in Vai di Crati (Calabria), Squillace ed Alife e duchessa di Sessa — per aver sposato il duca Giovanni Antonio Marzano — il bosco «nemus et territorium Sancti Gervasii cum Palatio, seu domo, situm in Pro vincia Basilica tae, tribus finibus, limitatum pro pe tenimentum Ecclesiae Sanctae Mariae de Bantia etc...
Poiché nel regesto si parla solo di «territorium Sancti Gervasii», sembrerebbe che ivi non si fosse ancora costituito un casale a mo di paese, invece è proprio di questo periodo il formarsi dell’agglomerato di abitanti — sia del piano che del villaggio di Santo Spirito che era stato il primo a sorgere intorno al castello —, i quali, forse sollecitati dalla nuova feudataria, iniziarono a dar vita al casale che continuò ad essere chiamato Palazzo San Gervasio in onore di uno dei due martiri cristiani, al quale era stata intitolata la prima chiesa’ sorta vicino al castello o addossata al Palazzo regio che era stata la prima costruzione sorta in quel luogo.
Intanto dal matrimonio di Giovan Francesco con Eleonora era nato un figlio a cui fu posto il nome di Giovan Battista, che in seguito sposò la vedova di Federico del Balzo principe di Altamura, Costanza d’Avalos, figlia di don Inigo marchese di Pescara, dalla quale però non ebbe figli maschi e mori nel 1507.
Cosi si estinse la famosa dinastia dei Marzano-Ruffo e di Cubella, principessa di Rossano, contessa di Montaito, duchessa di Sessa, e signora di Palazzo San Gervasio. Alla morte del duca il ‘Feudo di Palazzo San Gervasio’, con il relativo castello, tornò alla Regia Corte, per diritto di devoluzione feudale.
Orbene dopo la pace di Blois e con l’avvento al trono di Napoli di Ferdinando il Cattolico, il ‘Feudo’ di Palazzo — con tutto il castello e le pertinenze — che frattanto era ritornato —come prima si è detto — alla Regia Corte (1507), fu dato, addi 28 maggio dello stesso anno, «ab invictissimo rege Ferdinando facta in beneficium privilegio concessionis, feudi seu territori Palati Regiae» ad uno dei suoi più devoti baroni: Nicola Maria Caracciolo marchese di Castellaneta «cum hominibus vassallis vassallorum reddittibus» come da Diploma dei Regi Quinternioni della Regia Camera al fol. 51 e come rilevasi anche dal primo documento’ riportato dallo storico Nino Corteseso, che cosi suona:
20) «E’cambi dati per la prefata M.stà a il socto scripti baruni et gentili homini che possedevano le soctoscripte terre et pheudi del Stato del antescritto conte de Conza» (prov. Avellino). «Ad Cola Maria Caraczulo, per Palo, li è consignato lo casale et pheudo de San Gervaso, cioè, de le dece parte, le sei con pacto che li va’alli siano soi, et ha pagati ducati tre mila ad Sua Aitecza, et hebbe dicta parte de San Gervazo per ducati cinquecento et cento sopre li fochi et sali de la Bella con condicione che quando serranno vinute le informaciune de dicto casale et pheudo, se habia a crescere o minuire de li dicti cento ducati de fochi et sali escundo se trovarrà valere dicto pheudo, taliter che in tutto habbia ducati seicento integri».
Sennonché, dopo diversi anni, con la successione al trono di Spagna e dei possedimenti napoletani dell’imperatore d’Austria Carlo V d’Asburgo (1516) e a causa di rivolgimenti che si verificarono nel Regno di Napoli tra il 1527-30, ad opera di alcuni baroni autoctoni, il nuovo Signore, in data 30 giugno del 1532 — come da copia estratta dai Regi Quinternioni della Regia Camera —, concedeva con suo privilegio «ob ribellionem marchionis Castellanetae ab imperatore Carlo V» il ‘feudo’ di Palazzo San Gervasio, con tutti i diritti, fra cui quelli di «mercaturae, ponderum, et mensurarum etc...», in favore di un barone spagnolo suo favorito, Ferrante o Ferdinando di Alarcòn de Mendoza marchese di Rende e della Valle Siciliana «cum omnibus et singulis ipsarum terra rum et locorum casalibus, castris, fortilliis, vassallis, vassallorum reddittibus, fundis qua ternatis et non quaternatis etc...
Nel secondo documento del 1531 riportato dal Cortese ed estratto dal suddetto archivio de Simancas, si legge in lingua spagnola quanto segue:
29) «Esta tierra fuè de Cola Maria Carachulo marques rebelle y condenado, concedida por el Principe al marques Alarcòn. Esta tierra tiene toda jiurisdicio y buenos terminos y es frutifera de grandos y herbaies: tiene fuegos C’ y un Castillo razonable es tierre murada y de buenas qualitades. Valen las venderre quattro. mil ducados de oro ».
30) «Ei territorio o fego illamado lo palazzo en la mesma Provincia, del mesmo marques. Este fego concedito al dicho marques Alarcon y tiene grandes territorio; tiene dehesas, herbaies y bosques a Sancto Gervasio. Vale este territorios, segun parece en le cedulario de la doa, mii escientos sessanta ducados, de los quales solia pagar la Regia Corte por los herbaies de las pecoras de la Regia Doana DCC ducados al ano; los quales seria bien que se reintegrasen libre el pasto a la Corte».
In tal modo il ‘Feudo’ di Palazzo con tutto il castello e pertinenze ed agglomerato di case che costituivano il casale, passò dalla casata del marchese Nicola Maria Caraccioio, dichiarato ‘perduello’ e nemico della nuova dinastia, a quella del marchese spagnolo Ferrante di Alarcòn de Mendoza. E come questo feudo cosi anche tanti altri vennero confiscati e distribuiti a capitani spagnoli e italiani che si erano mostrati devoti all’imperatore, il quale governò il reame per mezzo di un Vicerè che aveva sede in Napoli; il più importante dei quali fu D. Pietro Alvarez de Toledo (1532-1553) marchese di Villafranca a cui i napoletani riconoscenti dopo la morte intitolarono una delle vie più importanti della città.
Purtroppo anche i beni del marchese Ferdinando di Alarcon — come rilevasi dal Cedolario del Grande Archivio di Napoli — dopo più di trènta anni, nel 1564, furono posti in vendita e comperati per 43.550 ducati da Donna Lucrezia della Tolfa, marchesa di Lavello, il cui padre si era distinto nel 1532 con il Comandante Andrea Doria, genovese, ammiraglio di Carlo V, con 300 archibugieri napoletani all’impresa di Corone (Grecia) contro i Turchi nel Levante — cosi come narra lo storico coevo Gregorio Rosso.
Intanto già, solo sul trono di Spagna, come re, era succeduto ai padre Carlo V, morto il 1556, il figlio Filippo Il il quale per il governo dei domini spagnoli in Italia, continùò a servirsi di un Vicerè il più importante dei quali fu D. Perafan de Rive-ra, duca d’Alcaià, che governò il Reame dai 1558 al 1571.
Nel 1569 moriva la marchesa Donna Lucrezia della Toifa, lasciando il ‘Feudo’ di Palazzo ai figli Giangirolamo e Giovannantonio. Ma, morto scapolo il primo, il ‘Feudo’ veniva ereditato in toto dal secondo. Nel 1587 San Gervasio è posseduto da Giovanni Antonio del Tufo al quale succede nel 1590, il figlio primogenito Carlo del Tufo55, che oberato da debiti e ad istanza dei suoi numerosi creditori, vendette nel 1597 la terra e parte dei ‘Feudo’ al duca di Acerenza D. Galeazzo Pinelli che l’acquistò per 74.500 ducati.
Nel 1600 a Galeazzo successe il figlio Cosimo ed a questi il figlio Galeazzo Francesco Pinelli, il quale nel 1615 vendette la terra di Palazzo San Gervasio, «alias lo Palazzo», al signor Antonio Cattaneo di Genova.
Nello stesso anno il ‘Feudo’ suddetto passava da Antoniotto alla sorella Ippolita Cattaneo e alla morte di costei all’altra sorella Costanza che aveva sposato Giovanni De Marinis di origine spagnola e feudatario di Genzano.
Nella Spagna intanto, a Filippo Il era succeduto il figlio Filippo III (1598-1621) e a questi il figlio Filippo IV (1621-1665) e nel 1665 il figlio di costui Carlo Il che regnò fino al 1700, anno in cui, morendo senza successori, dette luogo alla guerra di Successione Spagnola.
Nel frattempo i figli di Costanza e Giovanni De Marinis, A Giambattista e Stefano, eredi del feudo in parola, comprarono anche nel 1616, per 70.352 ducati le altre due parti del ‘Feudo’ di Palazzo San Gervasio dal marchese Andrea del Tufo, nipote di Carlo già menzionato, il quale le aveva comprate il 23.11.1585 dagli eredi del duca Pinelli, ottenendo anche il titolo di marchese di Genzano.
Nel 1631, morto celibe Giovanbattista, il ‘Feudo’ passò al fratello D. Stefano che aveva sposato la signora Giovanna Grimaldi, anch’essa oriunda genovese. Costoro ebbero una sola figlia: Paola Maria De Marinis che sposò il cugino Giovanbattista Grimaidi. Da questo matrimonio nacque un solo figlio, Orazio, il quale alla sua morte avvenuta nel 1698, non avendo avuto eredi, lasciò come erede testamentario del ‘Feudo’ di Palazzo San Gervasio un loro parente, il marchese di Genzano: Giangiacomo De Marinis, che, essendo morto celibe il 19 giugno del 1765 (siamo già ai tempi di Ferdinando IV di Borbone re di Napoli — 1759-1806 — succeduto al padre Carlo III, passato a reggere il trono di Spagna), lasciò erede di tutte le sue sostanze il nipote D. Giovanni Andrea De Marinis, feudatario sino al 1806, finché con la legge del 2 agosto dello stesso anno, fu abolita la feudalità — iniziata con i Longobardi — da parte di Giuseppe Bonaparte, fratello del grande Napoleone e Re di Napoli dal 30 marzo del 1806 al 15 giugno dei 1808, cui succedette il cognato Gioacchino Murat che regnò dal 15 luglio 1808 al 20 maggio del 1815, anno in cui dopo aver emanato il celebre Proclama di Rimini (30.3.1815), opera di Pellegrino Rossi, con il quale invitava gli italiani a combattere con lui per l’indipendenza e per l’unità d’Italia 60, subi tra il 2 e il 3 maggio la sconfitta di Tolentino da parte degli austriaci e dovette firmare la Convenzione di Casa-Lanza presso Capua per la quale il trono di Napoli era restituito a Ferdinando di Borbone. Subito dopo, volendo riconquistare il Regno di Napoli, sbarcò con un manipolo di volontari a Pizzo di Calabria, ma, preso dalla gendarmeria locale e processato sommariamente dalle truppe borboniche, fu ivi fucilato il 13 ottobre dello stesso anno.
E, ironia della sorte, l’unico figlio maschio del marchese Giannandrea De Marinis, signore di Genzano e di Palazzo San Gervasio, D. Filippo partecipò attivamente come patriota alla Costituzione, addi 23 gennaio 1799, della Repubblica Napoletana, ma, caduta questa il 23 giugno, fu preso e sottoposto, poi, a procedimento penale dalla Suprema Corte dello Stato borbonico che lo condannò alla pena capitale il 23 settembre del 1799; la sentenza venne eseguita il primo ottobre dello stesso anno.
Il padre Giannandrea mori invece vecchissimo lasciando tutti i suoi beni all’unica figlia Costanza che intanto era andata sposa a D. Giuseppe de Sangro, principe di Fondi. D. Costanza, in tal modo, divenne principessa di Fondi, feudataria di Poggio Marino, signora di Oppido Lucano, Marchesa di Genzano, e di Palazzo San Gervasio.
Fu proprio in questo periodo che il castello di Palazzo che già nel sec. ‘V aveva subito un primo saccheggio ad opera di vandali, fu fatto riattare e riportare al suo antico splendore dalla stessa D. Costanza.
Ma i coniugi de Sangro-De Marinis, non avendo avuto anch’essi dal loro matrimonio alcun figlio, lasciarono, ab intestato nel 1832, eredi dei loro beni: sia D. Francesco de Sangro fratello di D. Giuseppe, che, alla sua morte, la moglie Donna Luisa Gabrielli, madre di tre figlie: tra le quali vennero poi divise le immense ricchezze.
Cosi aveva fine il ‘Feudo’ di Palazzo San Gervasio, che le leggi eversive del 1799 sulla feudalità, già ricordate, e la divisione delle terre demaniali e feudali del 1800, avevano già incominciato a sgretolare.
Le tre figlie dei coniugi de Sangro-Gabrielli si sposarono: la prima, Donna Maddalena, con il marchese D. Giulio de Majo; la seconda, Donna Mariantonia, con D. Troiano Marulii, Principe di Sant’Angeio; la terza, Donna Carmela, con il Cav. Prospero Piscicelli, dottore in ambo le leggi, la quale però, dopo non molto, rimase vedova.
E l’antico Palatiùm regium, ossia il castello baronale, che ancor oggi si erge maestoso con la sua mole sul cucuzzolo di un conglomerato roccioso che domina la sottostante vallata ed èubicato al centro della strada che i cittadini riconoscenti — come già si è detto — intitolarono a re Manfredi, fu ereditato dalla Principessa donna Carmela De Sangro, vedova Piscicelli e da questa lasciato ai figli che lo vendettero ad alcuni proprietari privati che tuttora ne sono in possesso, mentre la parte sottostante appartiene al Comune.
In esso si accede attraverso un ampio portale con un arco di stile romanico ancora ben conservato che dà in un cortile ove si affacciano le porte di diversi locali, alcuni dei quali adibiti, sia anticamente che fino a prima della ultima guerra mondiale, a carceri; addossata al muro proprio, di fronte all’ingresso, trovasi una scalinata ormai sconnessa, ma che una volta doveva spiccare per armonia e decoro.
Essa porta su di un pianerottolo sul quale vi sono ancora degli accessi che danno nei diversi appartamenti formati da ampie stanze, in tutto una quindicina, che ormai hanno subito varie trasformazioni, sia per quanto riguarda i pavimenti che le volte, di cui alcune sono ancora a botte con travi in legno e molto probabilmente coeve con il complesso della costruzione. In talune stanze esiste qualche caminetto antico che però niente ricorda del tempo in cui svolgeva l’importante compito di riscaldare i vasti ambienti e i suoi abitanti nelle rigide giornate e specie nelle lunghe serate invernali in un castello isolato, posto cosi in alto e per giunta esposto ai venti che lo investono da ogni parte.
Però al tempo della principessa di Fondi D. Costanza, figlia del marchese Giannandrea De Marinis, le stanze erano quasi sempre allietate dalla presenza di questa nobildonna che aveva gusti raffinati ed elevatezza di spirito, a detta dell’Ing. Arch. Giuseppe d’Errico (1818-1874), suo contemporaneo e di Palazzo San Gervasio, del quale ci è pervenuto attraverso eredi un breve manoscritto da cui si rileva che la gentile signora teneva ben arredate le sale del castello con ricchi mobili e con quadri di celebri artisti che l’adornavano: una vera, piccola, ma graziosa ed importante pinacoteca con dipinti raccolti con cura, gusto e signorilità. «Nelle diverse sale — racconta il d’Errico — vi erano quadri di artisti della scuola napoletana del ‘600 e dei ‘700; sospeso al muro della parte ovest del castello, vi era un dipinto del maestro napoletano del Seicento: Domenico Gargiulo detto Micco Spadari (1612-1679), e che raffigurava Mosé mentre si accingeva a varcare, con il popolo di Israele, l’arabo Reno». Sulla riva opposta vi erano rapresentati da una parte gli Israeliti che ammiravano stupefatti le falangi del Faraone che venivano sommerse dal fiume che si apriva sotto di loro; dall’altra i Patriarchi che mormoravano contro il loro condottiero, mentre questi, con la sua verga magica, sommergeva l’esercito egiziano nella profondità dell’Eratno.
Molte di queste opere furono in seguito acquistate dalla famiglia d’Errico da parte di D. Camillo (1821-1897), sindaco di Palazzo per ben trent’anni a, munifico mecenate e cultore di belle arti, il quale costituì poi una raccolta straordinaria di quadri di ingente valore artistico costituenti la pinacoteca d’Errico fondata dallo stesso con 298 quadri d’autore celebri della Scuola napoletana e un centinaio di tele.
Intanto attualmente per l’ignavia dei passati e recenti uomini al potere, sia in sede comunale che provinciale e regionale e, perché no, anche nazionale, trasparente in ogni azione di assoluto disinteresse verso quanto li circonda, l’antico Palatium regium, ovvero il Castello marchesale, è nelle mani di privati cittadini; ed è abbastanza evidente la trascuratezza che costoro dimostrano verso un patrimonio di valore storico che la natura, più prodiga, ad onta dei secoli trascorsi, ha conservato quasi inalterato.
Ed anche se le moderne infrastrutture urbanistiche hanno portato ad invadere l’area di rispetto delle opere antiche questo antico maniero, costruito su di un pilastro di roccia compatta, sfidando l’eternità con la sua maestosa semplicità, è la testimonianza più viva ed evidente di un’epoca storica in cui i nostri avi, in un anelito di estrinsecazione, vollero lasciare a noi posteri quest’opera come espressione di un loro modus vivendi e come un attestato della loro capacità e sensibilità artistica.